Il video di uno studio di registrazione completamente deserto. Il silenzio assordante, da pagina bianca che arriva in cuffia. Questa potrebbe essere la musica di un domani, se sarà concesso all’IA di aggirare la tutela del copyright.
“Nella musica del futuro, le nostre voci resteranno inascoltate?”, ha dichiarato in maniera provocatoria la cantante Kate Bush, evocando con efficacia la prospettiva di un mondo alieno, senza persone in cui la musica sarà inghiottita da un rumore di fondo perenne: quello dei sensori e dei movimenti delle macchine.
Oppure un altro futuro, meno technoir ma non meno agghiacciante: quello in cui l’uomo rinuncerà a esprimersi.
La cantante, che non compariva in un album in studio dal 2011, ha voluto omaggiare con il suo nome partecipando ad un disco che usa il silenzio come strategia di protesta contro una decisione politica.

Preferisci il podcast?
Ogni puntata trasforma il post del blog in un racconto da ascoltare.
Il copyright, la musica e l’IA
Is This What We Want? è un silent album composto da dodici tracce a cui hanno partecipato più di un migliaio di artisti famosi (oltre a Kate Bush, anche Paul McCartney, Elton John e Damon Albarn, solo per ricordarne alcuni).
Come siamo arrivati a questo?
Il governo inglese sta valutando di aprire una breccia nella proprietà intellettuale, e questo per concedere alle società tech di addestrare i propri modelli di IA (intelligenza artificiale generativa) con la musica coperta da copyright.
Tale breccia consentirebbe agli sviluppatori di poter nutrire i propri algoritmi di machine learning senza riconoscere alcun compenso agli artisti o ai detentori dei diritti, a meno che non dichiarino esplicitamente la loro estraneità a partecipare (azione che sembra facile a dirsi, molto meno a farsi).
Ma facciamo un piccolo passo indietro.
Che cos’è il copyright?

Il copyright è uno strumento giuridico di difesa dell’opera di ingegno che nasce proprio in Inghilterra nel 1710 con lo Statuto di Anna.
Al tempo il problema nasceva in ambito editoriale. Era legato agli stampatori abusivi, cioè a quegli editori pirati che ristampavano i testi senza avere il diritto di farlo.
Lo Statuto di Anna riconosceva agli autori e ai loro aventi causa, cioè gli editori autorizzati, il diritto di stampa delle proprie opere. La durata di questo diritto era ventuno anni per le opere già pubblicate, e quattordici anni per quelle ancora inedite.
Sebbene aggiornato e integrato nei vari ordinamenti giuridici, nella sostanza il copyright è ancora oggi un monopolio a scadenza detenuto dall’autore o dal titolare dei diritti sull’opera d’ingegno (musica, libri, film, ecc.), che consente all’autore o al titolare dei diritti di concedere (o meno) l’autorizzazione per la copia dell’opera.
Copyright e diritto d’autore

Anche se attinenti alla sfera della proprietà intellettuale, il diritto d’autore e il copyright non sono identici.
Semplificando molto, i sistemi giuridici di civil law, il cosiddetto diritto continentale che deriva dal diritto romano, tutelano l’autore in quanto soggetto.
Invece i sistemi giuridici di common law, come il diritto anglosassone, pongono la centralità sull’oggetto della creazione, e sulla riproduzione e l’utilizzazione dell’opera d’ingegno.
Nella tradizione continentale, a cui appartiene anche la legge italiana sul diritto d’autore, tale diritto si compone di due elementi:
- il diritto alla pubblicazione e all’utilizzazione economica, temporaneo e alienabile, cioè cedibile a terzi.
- Il diritto morale dell’autore, che attesta la paternità dell’opera, diritto riconosciuto invece come perpetuo e inalienabile.
La proprietà intellettuale della musica nell’era digitale
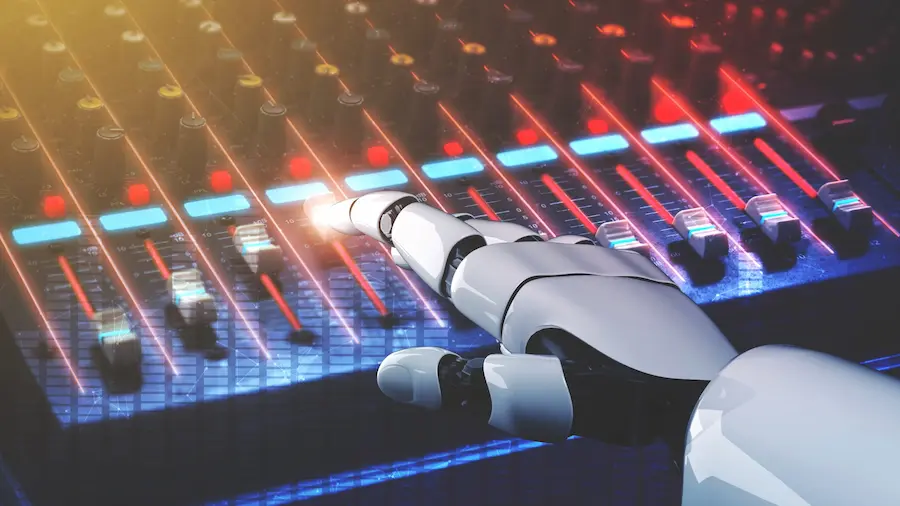
Già dagli anni ‘80 con i progressi tecnologici nell’ingegneria del suono e la diffusione dei campionatori digitali era avvenuto qualcosa di spettrale e irriverente, ma molto significativo: si poteva campionare.
Il campionamento digitale consentiva di isolare e copiare una porzione più o meno grande di una traccia audio pre-esistente (un jingle pubblicitario, una canzone, o un’intera colonna sonora), creando così una traccia nuova.
O resuscitando materiale musicale morto e dimenticato.
Attraverso la pratica del sampling, il campionamento, i primi rapper e produttori hip-hop avevano mostrato come tutta l’industria musicale si reggesse su una parodia di proprietà.
Spesso chi rivendicava il furto di una canzone, gridando al plagio, non rendeva conto a sua volta di aver preso in prestito materiale e strutture appartenenti a un’intera tradizione o una cultura.
La tecnologia non ha creato il problema, lo ha semplicemente spostato sotto i riflettori. E a seconda dell’uso e dello scopo, la tecnologia digitale ha rivestito ruoli opposti nel corso del tempo.
È passata da essere la minaccia più grande alla creatività e all’ingegno umano (si pensi a Napster, Pirate Bay e alla crisi dell’industria discografica all’inizio del millennio), per arrivare a diventare l’estremo baluardo di difesa della cultura collettiva contro la pirateria (basti pensare al lavoro di Google per la creazione del Book Right Registry, o al ruolo giocato dalle piattaforme di streaming musicale come Spotify).
Anche i ruoli spesso si confondono in questa storia. Da una parte della barricata ci sono i detentori dei diritti che difendono gli artisti e vestono i panni dei salvatori del patrimonio culturale.
In realtà questi gruppi sono organizzati spesso nella forma di grandi società editoriali e discografiche, invece che in collettivi di autori o musicisti, società avverse al dominio pubblico o all’esistenza di una cultura collettiva.
Dall’altra abbiamo le piattaforme digitali, e oggi le società di IA, che promettono una libertà di riconfigurazione più democratica al patrimonio culturale attraverso la tecnologia.
Senza tenere però conto di chi lo ha creato questo patrimonio, e soprattutto estraendo dati e risorse culturali per interessi privati.
Torniamo all’IA.
Intelligenza artificiale, una faccenda politica
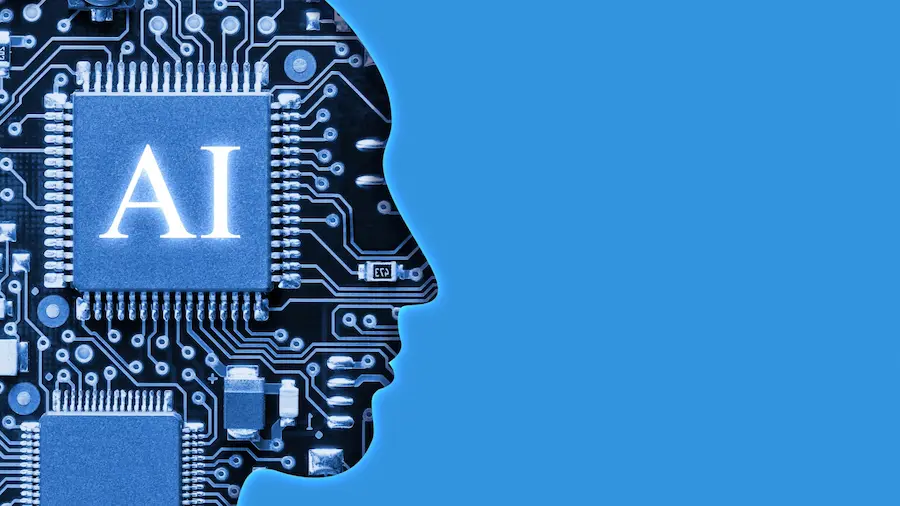
Gli antichi colonizzatori potrebbero essere colonizzati. Perché quando nominiamo l’industria dell’IA, ad oggi, facciamo riferimento in prevalenza a società nordamericane (Anthropic, Nvidia, OpenAI, Meta, Grok, giusto per ricordarne alcune).
Sebbene gli obiettivi del governo britannico di Starmer con questa apertura a Big Tech restino ancora oscuri (tendere una mano agli Stati Uniti di Trump?), la decisione potrebbe inaugurare un nuovo colonialismo, che invece di sfruttare le risorse naturali di un paese depreda quelle culturali.
In America intanto centinaia di creativi hanno di recente firmato una lettera per denunciare le possibilità di appropriazione indebita del loro lavoro da parte delle società di IA.
Google ha risposto che dal canto suo può appellarsi ad un cosiddetto ‘fair use‘, cioè un uso ‘equo’ del materiale protetto senza comportare una violazione. Ma la questione è piuttosto spinosa e dibattuta.
Ricordo come lo scorso anno ci sia stato un grandissimo sciopero ad Hollywood, quello che mi piace ricordare come “l’immaginario in sciopero”, perché ha coinvolto prevalentemente l’industria cinematografica.
Questo movimento, dopo più di cento giorni di sciopero, ha ottenuto una regolamentazione nei contratti per l’uso delle repliche digitali degli attori.
Insieme alla controparte discografica, il cinema di Hollywood rappresenta il principale muscolo del soft-power statunitense nel mondo, ed oggi l’IA mette a rischio più di due milioni di posti di lavoro nel settore.
Eppure l’amministrazione americana attuale ritiene che le regole siano carne avariata.
In occasione del vertice sull’IA di Parigi, il vicepresidente JD Vance si è lamentato che la regolamentazione in materia sia fin troppa, e che rischi di uccidere nella culla l’industria dell’intelligenza artificiale europea. Lo stesso Trump ha abrogato l’ordine esecutivo del suo predecessore Joe Biden per un piano di sviluppo dell’IA più attento e rispettoso.
La prospettiva di una desertificazione culturale non sembra preoccupare più di tanto l’amministrazione: del resto ci sono altre “piccole” questioni sullo sfondo (guerre commerciali, deportazioni di immigrati, chi ne ha più ne metta…)
Copyright con IA: la fine della musica o la fine del progresso tecnologico?

Com’era accaduto in un passato non troppo lontano con il campionamento, oltre a un dibattito sulla tecnologia e sulle regole per un uso dell’IA che rispetti il copyright della musica, sarebbe necessario capire cosa si intende per lavoro creativo oggi, come questo possa essere valorizzato, ed infine anche difeso.
Sembra sempre più evidente: l’idea romantica di un genio creatore che crea e possiede l’opera come un padre Saturno è arrivata al tramonto.
Piuttosto ci troviamo in una fase in cui il prodotto culturale viene concepito e letto come un segno, o un rimando ad un contesto inter-testuale più ampio. Un’opera aperta insomma.
Io però non credo nella morte dell’artista. Esistono ancora là fuori persone in carne e ossa mosse da un autentico impulso a scrivere, a registrare e a sporcarsi le mani. Anche se nella loro cassetta degli attrezzi compaiono, tra i vari strumenti, ChatGPT o DeepSeek.
La tecnologia, oltre a una potenziale minaccia, può offrire un aiuto alle persone che creano?
Intanto aiuterebbe andare oltre la retorica polarizzante, e cercare di comprendere l’IA, la tecnologia tout court e la proprietà intellettuale come elementi interconnessi.
Non solo esistono già accordi espliciti tra editori e società di IA (ne è un esempio il The Guardian), ma addirittura in certi casi la proprietà intellettuale sembra arrivare a tutelare le opere realizzate mediante l’intelligenza artificiale. Se ci pensiamo, queste nascono a partire dal prompt di un utente, che diventa il co-creatore.
Quando però l’intervento umano può ritenersi significativo, e non una mera imitazione di una macchina? Se interrogativi come questo ci suonano vuoti o eccessivamente filosofici, basti pensare che quest’anno tra i film candidati al David di Donatello c’è stato un cortometraggio completamente realizzato con l’IA.
Dunque, nella musica del futuro, potremmo ancora ascoltare le nostre voci?
Secondo me sì. Ma la questione, oltre che tecnologica e legale, è profondamente politica. Riguarda come vogliamo riorganizzare i “rapporti di produzione” culturale. E cosa sceglieremo di ritenere ancora umano e irriproducibile in una realtà che appare sempre più replicabile dalle macchine.
Bibliografia
- Bertinetto A., Gamba E., Sisto D. (a cura di), Ladri di musica. Filosofia, musica e plagio, «Estetica. Studi e Ricerche», IV, 1, 2014.
- Eco U., Opera aperta. Forme e indeterminazioni nelle poetiche contemporanee, (1962), Bompiani, Milano, 2013.
- Galli S., Visco P., Il diritto della musica. Diritto d’autore, diritti connessi e tutela della proprietà intellettuale, Hoepli, Milano, 2009.
- Johns A., Pirateria. Storia della proprietà intellettuale da Gutenberg a Google, Bollati Boringhieri, Torino, 2011.
- Kleon A., Ruba come un’artista, Vallardi, Milano, 2013.
- Quintarelli S. (a cura di), Intelligenza artificiale. Cos’è davvero, come funziona, che effetti avrà, Bollati Boringhieri, Torino, 2020.




